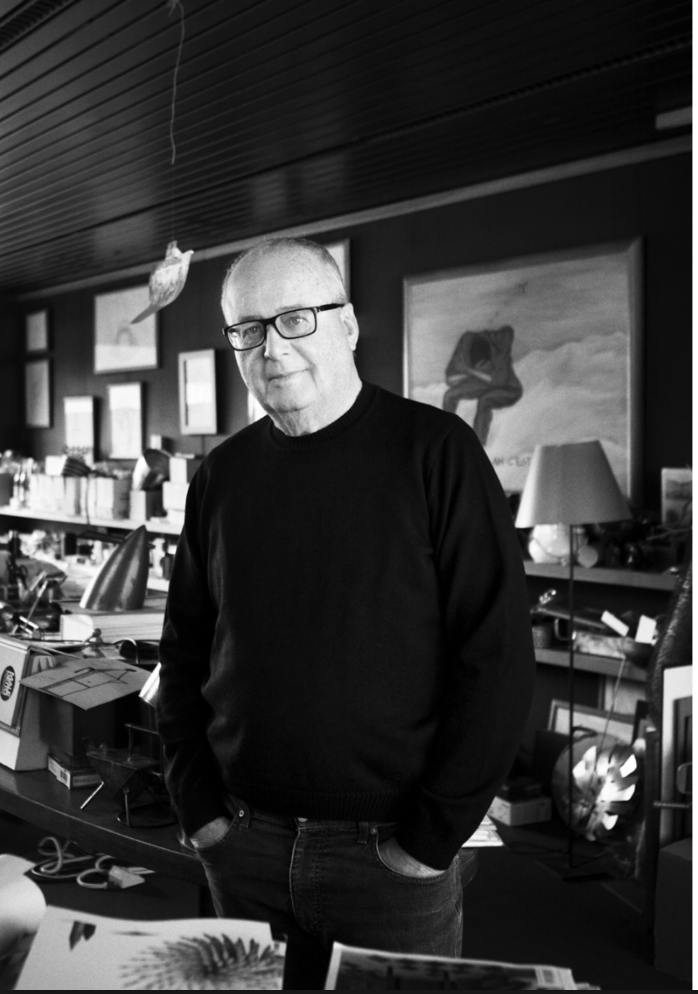Non toglietegli i suoi libri, i suoi laghi e le sue montagne. Alberto Alessi rifugge il perbenismo di certi cenacoli e preferisce starsene seduto nel suo studio stracolmo di prototipi, oggetti iconici e non finiti accogliendo il genio dei designer. Da oltre cinquant’anni entra ogni mattina nell’azienda fondata dal nonno a Omegna sul lago d’Orta e la trasforma nella sua fabbrica dei sogni.
Alessi è la perfetta sintesi tra arte e tecnica, tra design e industria. Quanto conta per lei l’Umanesimo?
Certamente l’Umanesimo è al centro del mio pensiero e della mia attività: cerco di diffonderlo in azienda, a volte con alcune difficoltà perché la cultura industriale oggi è fatta soprattutto di numeri ed è po’ arida. Per fortuna esistono nicchie, come la nostra, in cui si cerca di difendere una visione umanistica, ma sono realmente poche.
Dopo la laurea è entrato in Alessi portando una ventata d’innovazione: quanto ha influito la filo-sofia, l’arte, la poesia nel suo pensiero intorno al prodotto?
Quando ho iniziato la Alessi era una azienda come molte altre il cui obiettivo era quello di fabbricare e vendere oggetti, con una certa fierezza nel farli bene. In fabbrica c’era un clima severo e grigiastro, come l’acciaio. lo ho cercato di influenzare a poco a poco l’attività dell’azienda: non ho fatto volontariamente dell’Umanesimo, solo ciò che mi sembrava giusto nel contesto in cui mi ero trovato.
La sua formazione umanistica traspare anche nel suo relazionarsi con i progettisti: tra gli oltre trecento con cui ha lavorato, ce n’è uno che preferisce?
Onestamente no, ma Aldo Rossi è certamente nella triade dei designer che mi hanno più ispirato.
Era un “laghista” come me, aveva vissuto a lungo sul Lago di Mergozzo, di lui mi ha ispirato la fortissima vena poetica e il distacco ferreo dalle cose. Sembrava volasse sopra le cose. Di Sapper mi affascinava il suo essere un uomo forte, molto volitivo, quasi il contrario di Rossi. Mendini è stato il mio padre spirituale: mi ha introdotto nel mondo del design e da lui ho imparato come da nessun’altro.
Come si fa a coniugare il design con un’ azienda di estrazione metalmeccanica?
Quando sono entrato in Alessi c’era un’ eccessiva serietà e mi sentivo in dovere di portare un po’ di divertimento e novità. Così ho cominciato a invitare i primi designer.
Non è stato facilissimo, forse per la giovane età le prime operazioni che ho lanciato erano troppo teoriche. Con Alessi d’après ho pensato di usare le nostre macchine per produrre dei multipli d’arte, concepiti da scultori e venduti a un prezzo contenuto con l’idea utopica di portare l’arte a tutti. Con quell’operazione arrivai ai limiti del licenziamento e mio padre bloccò il progetto impedendo l’uscita dell’ultima scultura: una bellissima opera surrealista di Salvador Dalí.
Quanto la producibilità industriale di un oggetto condiziona la creatività di un designer?
Poco, tanto più che con la tecnologia contemporanea non ci sono limiti produttivi. Il vero limite è se c’è un pubblico interessato a quello che sto facendo e disposto a pagare il costo di ciò che voglio creare. Poi certamente per passare dal concept al prodotto reale c’è un lavoro di affinamento che, nel nostro caso, richiede da uno a due anni. È un lavoro indispensabile, il solo designer non può farlo perché non è un produttore.
Il genio come dialoga con gli aspetti puramente commerciali del prodotto?
Riguardo la nascita dell’oggetto sostengo la “teoria del buon giardiniere”: pianto i semi che mi sembrano utili e so che il vento ne porterà altri, magari più interessanti. I progettisti sanno capire e interpretare i movimenti sociali e culturali che stanno nascendo nella società, per questo mi sono trovato a ricevere progetti sorprendenti, proposte nuove che corrispondevano alle esigenze del pubblico.
Progetti solitamente non compresi dai commerciali che desiderano ciò che il mercato sta richiedendo.
I designer invece sono anticipatori del mercato, le loro proposte sono ben ancorate ai veri bisogni delle persone: il pubblico, contrariamente a quanto si può pensare, è costantemente alla ricerca di poesia
negli oggetti che acquista.
Può illustrarci la “Formula del successo” di Alessi?
Quella che ironicamente chiamiamo “Formula del successo” è un modello matematico che usiamo per fare previsioni su come il pubblico accoglierebbe un oggetto se lo mettessimo in produzione.
Si basa su quattro parametri, ciascuno dei quali è misurato con un punteggio che va da uno a cinque: i primi due, centralissimi per la nostra attività, sono Sensorialità/memoria/immaginario (SMI) e Comu-
nicazione/Linguaggio (CL).
Il parametro SMI misura quanto piacerà un ogget-to, se le persone lo troveranno “bello”, ossia se colpirà piacevolmente i sensi, se aggancerà memorie positive e stimolerà l’immaginario.
Il parametro C/L misura l’attitudine dell’oggetto nel comunicare agli altri qualcosa di chi lo possiede.
La moda, per esempio, lavora moltissimo su questo parametro: gli abiti sono scelti e indossati dalle persone anche per raccontare aspetti di sé.
I parametri SMI e CL, che potremmo definire sog-gettivi, sono completati da due di natura più ogget-tiva: Funzione, che misura quanto l’oggetto risponda adeguatamente all’ archetipo della sua tipologia,
e Prezzo.
Alessi ha compiuto cento anni ma lei dice di essere più interessato alla capacità di portare sempre nuove idee. Qual è il suo reale rapporto con la tradizione?
lo sono un gran tradizionalista a dispetto di quello che vado in giro a raccontare. La tradizione produttiva della mia azienda mi è carissima, a partire da mio nonno che era un tornitore. Non si può progettare il proprio futuro se non si conosce a fondo la propria storia.
E però anche vero che per mestiere devo guardare al futuro: un buon design dovrà sempre rappresentare il mondo in cui ci troveremo.
E il futuro del design come sarà?
Non ne ho proprio idea. Il motivo per cui mi alzo ogni mattina è la curiosità di capirlo. L’ultima cosa che mi preoccupa è di interpretare io il futuro del design, noi facciamo dei tentativi per capirlo: proviamo a lavorare con nuovi designer, con nuovi mondi della creatività. Non sono di certo prescrittivo verso il futuro, sono attento ai segni che arrivano, cerco di elaborarli e capire se possiamo farli nostri.
La sua continua tensione per la ricerca è un atteggiamento tipicamente umanistico. Non crede?
Non saprei. So però che quando ricevo un progetto che capisco completamente non sono molto felice.
Un progetto valido deve contenere qualcosa che io non capisco o a cui non sono preparato.
Quale dovrebbe essere secondo lei la responsabilità culturale di un imprenditore oggi?
Quando ero giovane Sottsass mi diceva sempre che come imprenditore avevo delle grandi responsabilità, anche di natura culturale, perché riempivo – e riempio ancora oggi – le case delle persone di oggetti che incidono sulla loro vita. Quando parlo di cultura industriale non intendo la cultura immanente della produzione in serie, quella culturalità industriale, parafrasando le parole di Baudrillard, «che ci ostiniamo a chiamare cultura a costo di tutti i malintesi, di quella strana sostanza fatta di messaggi, testi, immagini, best-sellers o fumetti, di quella creatività codificata che ha sostituito l’ispirazione e la sensibilità». Parlo della consapevolezza della responsabilità di lavorare «anche nell’iperfunzionalismo di una cultura sciupata, verso l’universale, verso la trascendenza di nuovi miti che potrebbero decodificare la nostra epoca senza esserne delle superproduzioni mitologiche; verso un’Arte (una nuova forma di arte) che potrebbe decifrare la nostra modernità senza dissolversi in essa».
Alberto Alessi/
Presidente di Alessi s.p.a., responsabile per il design management, il marketing strategico e la comuni-cazione. A partire dal 1970 ha trasformato la Alessi portandola a diventare uno dei grandi nomi del design internazionale. Sui temi del design ha scritto li-bri, articoli e curato mostre, occasionalmente è stato visiting professor in università internazionali. Affianca all’attività in Alessi la produzione di vini biodina-mici con l’etichetta “La Signora Eugenia e il passero solitario”; nel 2016 è stato nominato Chevalier du Tastevin dalla Confrérie des Chevaliers du Tastevin.